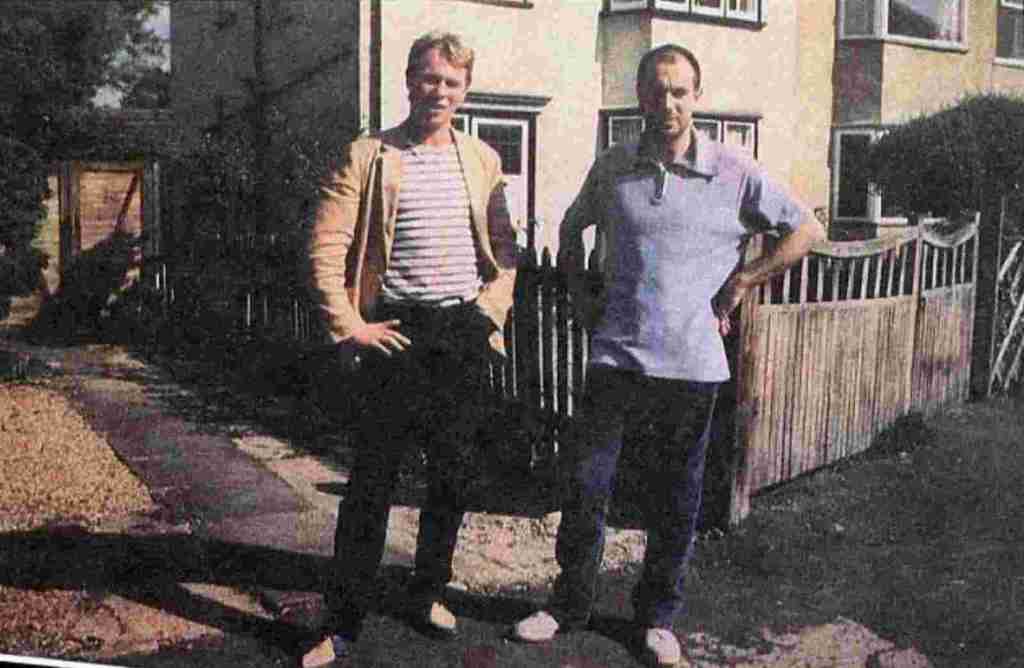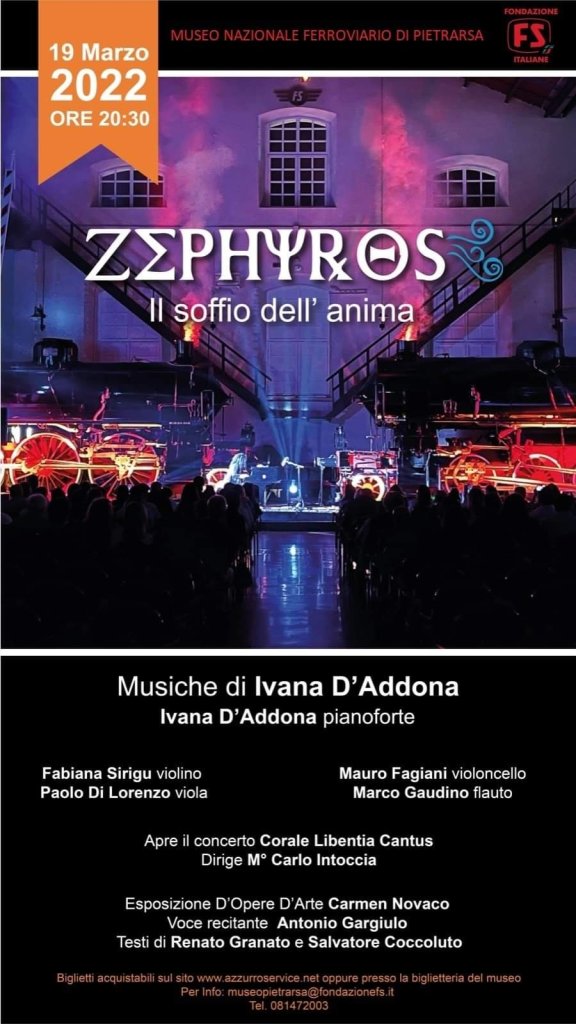Negli anni duemila ho intervistato Eugenio Finardi diverse volte: prima per Il Fatto Quotidiano, poi per Leiweb, nei giorni della sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2012. Tra le due occasioni, nel 2011 ci sentimmo anche per un’intervista che sarebbe finita nel mio libro “Il tempo della musica ribelle. Da Cantacronache ai grandi cantautori italiani”. Desideravo infatti sapere da lui quanto le realtà musicali di Cantacronache e del Nuovo Canzoniere Italiano avessero influenzato la sua di “musica ribelle”. Come sempre Finardi fu molto sincero, non risparmiando anche qualche critica all’approccio di alcuni membri del Nuovo Canzoniere Italiano. A distanza di tredici anni ripropongo quell’intervista in cui emergeva un interessante spaccato della nostra storia musicale.
Eugenio, tu sei entrato nel mondo della discografia nei primi anni Settanta. Che ricordo hai dell’ambiente musicale dell’epoca?
Sono entrato nel mondo discografico nel 1973. A quei tempi ci si ritrovava alla Galleria del Corso, come ha raccontato anche Pagani nel suo libro, e lì si creavano formazioni musicali nuove. C’erano degli appartamentini, dove attualmente ci sono le Messaggerie Musicali e la Sugar, con delle stanzette e in ognuna c’era un pianoforte, un compositore e un paroliere. Qualcuno arrivava e magari chiedeva di un bassista da inserire nel proprio gruppo. Io fui scelto, nel lontano 1971, come chitarrista di Marino Marini ed entrai nell’ambiente dove poi ho conosciuto Mauro Pagani, Alberto Camerini e altri amici. Nel 1973 fui preso dalla Numero Uno di Battisti. È lì che conobbi Lucio, Lavezzi, Mogol, il produttore Claudio Fabi, papà di Niccolò. La direttrice artistica era Mara Maionchi. Proprio nelle stanze della Numero Uno incontrai Demetrio Stratos. Tra di noi nacque una bella amicizia. Fu lui a presentarmi Gianni Sassi. E da lì iniziò il mio percorso artistico.
Il tuo primo album, “Non gettate alcun oggetto dai finestrini“, uscì nel 1975. Il disco conteneva la cover “Saluteremo il signor padrone”, canto popolare lanciato da Cantacronache. Come mai scegliesti di inserire questa canzone nell’album?
L’idea nacque per gioco. A me e ad Alberto Camerini divertiva molto riprendere brani che a livello musicale risultavano abbastanza noiosi. Così decidemmo di dare a questo pezzo una propulsione rock. Venimmo criticati tantissimo, soprattutto dalla Marini, per quel tipo di arrangiamento. Per loro era un sacrilegio rimaneggiare in versione rock quella canzone. A livello musicale eravamo troppo europei per essere compresi a pieno.
Quanto è stata influenzata la tua musica dal lavoro di riscoperta del canto sociale svolto da Cantacronache e dal Nuovo Canzoniere Italiano?
Noi eravamo influenzati moltissimo da Oreste Del Buono, il quale era proiettato in avanti, verso l’elaborazione e la personalizzazione della tradizione popolare. Ivan Della Mea e Giovanna Marini, invece, tendevano ad essere diffidenti verso questo tipo di approccio. Un atteggiamento buonissimo dal punto di vista filologico, ma che secondo me frenava l’evoluzione e la crescita. Il lavoro del Nuovo Canzoniere Italiano è stato grandioso dal punto di vista della ricerca e della riscoperta, ma un po’ meno da quello della rilettura della tradizione e della sperimentazione musicale. Noi volevamo fare rock italiano basato sulle nostre radici. Loro, invece, sono rimasti esageratamente fermi sulle loro posizioni senza risparmiare critiche a noi che invece volevamo sperimentare nuove soluzioni musicali. Questo, secondo me, è stato il loro grande limite.
Sempre a metà degli anni Settanta, dopo l’uscita del tuo primo album, hai fatto da spalla prima a Fabrizio De Andrè e poi alla PFM. Quanto ha segnato quella esperienza la tua produzione discografica successiva?
Pochissimo. Lo so che sembrerà strano. Io e Alberto Camerini avevamo delle radici musicali che affondavano in Woodstock e l’Isola di Wight. Eravamo figli dei Beatles e dei Rolling Stones. Per noi tutta la musica italiana era una cagata pazzesca, a parte la musica popolare, che appunto prendevamo dal Nuovo Canzoniere Italiano. Dietro questa nostra posizione c’era una motivazione ideologica legata alla possibilità di edificare, dalla tradizione musicale popolare, il nuovo rock italiano. La mia amicizia con De Andrè non nacque da un’affinità artistica. Io conoscevo pochissimo del suo repertorio e quel poco non mi piaceva nemmeno particolarmente. E lui apprezzava questo fatto. Era contento che io non lo trattassi come una santa reliquia. Il nostro era un rapporto critico, ma molto costruttivo. Anche Dori (Ghezzi) lo ricorda bene. Spesso gli dicevo: “Fabrizio, perché voi cantautori ripetete la stessa frase alla fine della strofa, inventatene un’altra!” E lui mi spiegava che era un richiamo alla tradizione popolare. Così io comprendevo il suo mondo e la sua musica.
Gli anni Settanta sono stati anni molto difficili a livello sociale e politico. Tra i giovani c’era un fermento implacabile e spesso i cantautori venivano contestati. Anche De Gregori e De Andrè non rimasero immuni da questi attacchi. Questa contestazione toccò anche te?
Noi eravamo parte attiva del Movimento. Io e Alberto Camerini abbiamo cominciato a cantare in italiano perché volevamo dare una mano. Quando iniziò il casino, ovvero quando fecero il processo a De Gregori, noi non smettemmo. Anche perché avevamo la coscienza pulita. Io non ero diventato ricco appoggiando il Movimento. Io avevo guadagnato qualche soldo facendo concerti. Quindi, al momento in cui molti miei colleghi smisero di suonare per il clima che si era creato intorno a loro, io continuai sulla mia strada, insieme agli Area e a qualcun altro. Furono comunque giorni molto duri.
Tu hai sempre avuto un’attività live intensissima. Anche negli anni Settanta hai fatto centinaia di concerti. Ricordi qualche episodio particolare accaduto durante una delle tue esibizioni?
Sì, certo. Ai tempi, i concerti spesso venivano interrotti per tenere comizi. Una volta ci trovavamo al mercato dei fiori di Brescia e un tipo salì sul palco, da solo. Lo lasciammo parlare perché sarebbe stato antidemocratico non dargli spazio. Ma lui, all’improvviso, fece il grande errore di prendere a calci i pedali del chitarrista. A quel punto, lo prendemmo in due e lo sbattemmo giù dal palco. Ci rimase in mano un’abbondante ciocca dei suoi folti capelli. Queste erano forme di narcisismo e di cialtroneria che non sopportavo.
Cosa ti spinse, alla fine degli anni Settanta, a rallentare con l’attività live e a “rifugiarti” fuori Milano?
Il clima a Milano era molto pesante. Io avevo subito varie intimidazioni. Mi bucarono le gomme della macchina. Addirittura una notte venni anche seguito. Insomma, non c’era una bella atmosfera. E poi un ulteriore episodio che mi convinse a uscire fuori Milano fu la nascita di mia figlia Elettra con la Sindrome di down. Da quel momento iniziò il mio percorso come cantautore, forse dall’esigenza di analizzare ciò che mi stava succedendo. I miei anni Ottanta sono stati molto più duri e meno romantici dei Settanta.